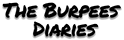Londra, una città che conosco come le mie tasche, essendo uno dei suoi pochi abitanti che si è preso la briga di girarla tutta e non solo il centro. Eppure eccomi qui, in una zona che non avevo mai esplorato prima, alla ricerca di un box CrossFit di cui avevo sentito parlare come di una leggenda urbana. Uno di quei posti che esistono da sempre, o almeno da quando il CrossFit ha messo piede in Europa nel 2007, ma che sembrano esistere in una dimensione parallela, conosciuta solo dagli iniziati.
Dopo aver girato in tondo per almeno mezz’ora – maledetto Google Maps che mi ha fatto fare il giro dell’isolato tre volte – finalmente lo vedo. O meglio, vedo un’insegna sbiadita che recita “CrossFit Something” (il nome è volutamente omesso per proteggere l’innocente… o il colpevole, a seconda dei punti di vista). È incastonata tra un negozio di kebab dall’aspetto discutibile e quello che sembra essere un ex lavanderia a gettoni ora convertita in un improbabile centro estetico low-cost, tra forti aromi di aglio e zenzero.
Mi avvicino alla porta, una specie di saracinesca industriale che ha visto giorni migliori, probabilmente quando Tony Blair era ancora al potere. C’è un campanello, o almeno credo sia un campanello. Potrebbe anche essere il pulsante per far detonare una bomba, visto lo stato in cui versa. Lo premo con cautela, mezzo aspettandomi di veder comparire la squadra artificieri dei SAS.
Invece, sento dei passi avvicinarsi dall’interno. La porta si apre con un cigolio che farebbe invidia alla colonna sonora di un film dell’orrore e mi trovo di fronte… beh, chiamiamolo coach. Un tizio sulla cinquantina, con una canotta che deve aver visto l’intera evoluzione del fitness moderno, dai tempi di Jane Fonda fino ad oggi. I suoi bicipiti raccontano storie di migliaia di curl, ma la sua pancetta suggerisce che forse quelle storie appartengono a un passato ormai lontano.
“Benvenuto al CrossFit Something!”, esclama con un entusiasmo che stride con l’atmosfera post-apocalittica del posto. “Sei qui per il drop-in?”
Annuisco, cercando di nascondere lo shock culturale che sto vivendo. Vengo da un box all’avanguardia nella Svizzera perfettina, educata, pulitina e precisina, con spogliatoi più grandi di questo intero edificio, attrezzature che sembrano appena uscite dalla fabbrica, e coach che potrebbero posare per la copertina di Men’s Health. Questo posto? Beh, diciamo che ha un certo… carattere.
Il coach, chiamiamolo Bob, anche se sono abbastanza sicuro che il suo vero nome sia qualcosa di molto più british, tipo Nigel o Rupert, mi fa cenno di seguirlo all’interno. Entriamo in quello che posso solo descrivere come un museo vivente del fitness funzionale.
Le pareti, un tempo probabilmente bianche, hanno assunto una tonalità che oscilla tra il grigio smog e il giallo nicotina. Sono tappezzate di poster motivazionali che devono essere lì dal giorno dell’apertura. “No pain, no gain” proclama uno, con un’immagine sbiadita di Rich Froning nella sua forma milgiore. “Embrace the suck”, dice un altro, con una grafica che sembra essere stata creata con Microsoft Paint, versione Windows 95.
L’attrezzatura… oh, l’attrezzatura. È come se ogni pezzo avesse una storia da raccontare, e non sono sicuro di voler ascoltare tutte quelle storie. Vedo bilancieri che sembrano aver vissuto due guerre mondiali, alcuni persino leggermente incurvati, kettlebell con più graffi di un gatto randagio e una rope climb che mi fa dubitare delle mie vaccinazioni antitetaniche.
“Allora”, dice Bob/Nigel/Rupert, interrompendo la mia ispezione mentale del luogo, “hai già fatto CrossFit prima, vero?”
Per un attimo sono tentato di dire di no, solo per vedere la sua reazione. Ma poi penso che potrebbe prendermi sul serio e farmi fare un on-ramp con attrezzature che potrebbero disintegrarsi al primo tocco.
“Sì, faccio CrossFit da un po’”, rispondo, cercando di non suonare troppo snob.
“Ottimo!”, esclama lui, come se gli avessi appena detto di aver vinto la lotteria. “Allora sai già come funziona. Gli spogliatoi sono là dietro, il WOD è scritto sulla lavagna. Iniziamo tra dieci minuti!”
Mi dirigo verso gli “spogliatoi” e uso il termine nel senso più lasco possibile. È più una specie di ripostiglio con alcuni ganci alle pareti e un paio di panche che sembrano essere state recuperate da un campo di rugby abbandonato. C’è un odore che non riesco a identificare, ma che sono abbastanza sicuro che non dovrebbe esistere in natura.
Mentre mi cambio, cercando di toccare il meno possibile qualsiasi superficie, noto che non sono l’unico ad essermi avventurato in questo tempio del fitness vintage. C’è un ragazzo, probabilmente sui vent’anni, che si sta cambiando con l’entusiasmo di chi non ha ancora imparato a temere le infezioni fungine. E poi c’è lui: un tizio che deve avere almeno settant’anni, con un fisico che farebbe vergognare la maggior parte dei trentenni che conosco.
“Prima volta qui?”, mi chiede l’anziano atleta, notando probabilmente la mia espressione di perpetuo shock.
“Si vede così tanto?”, rispondo con un sorriso imbarazzato.
Lui ride, una risata profonda e genuina. “Amico, ho visto quella stessa espressione su centinaia di facce negli ultimi dieci anni. Questo posto ha questo effetto sulle persone la prima volta. Ma fidati, è meglio di quanto sembri.”
Vorrei credergli, davvero. Ma poi guardo il soffitto e noto una macchia di umidità che sembra formare il volto di Gesù, o forse è solo Greg Glassman, a questo punto non ne sono più sicuro e mi chiedo se non sia tutto un elaborato scherzo cosmico. O forse siamo su Candid Camera.
Torno nell’area principale, dove Bob/Nigel/Rupert sta scaldando i motori con quello che sembra essere il suo personale rituale pre-WOD: bere una tazza di tè e mangiare un biscotto al burro. Perché no, dopotutto siamo in Inghilterra.
Mi avvicino alla lavagna per vedere il WOD del giorno e per un attimo penso di aver sviluppato improvvisamente la dislessia. Ci metto un po’ a capire che no, non è colpa mia, è che la lavagna sembra essere stata scritta da qualcuno in preda a convulsioni. Riesco a decifrare qualcosa tipo “AMRAP 20 min” seguito da una serie di simboli che potrebbero essere geroglifici egizi o la lista della spesa di un alieno.
“Ehm, scusa”, mi rivolgo al coach, che nel frattempo ha finito il suo tè, “potresti spiegarmi il WOD? Non riesco proprio a…”
“Oh, certo!”, esclama lui, come se fosse la cosa più normale del mondo avere un WOD scritto in codice. “È un AMRAP di 20 minuti: 15 wall ball, 10 pull-up, 5 power clean. Semplice, no?”
Semplice come la fisica quantistica, penso tra me e me. Ma annuisco, fingendo di aver capito tutto fin dall’inizio. Iniziamo il warm-up, e devo ammettere che, nonostante l’aspetto decadente del posto, Bob/Nigel/Rupert sa il fatto suo quando si tratta di preparare il corpo all’allenamento. Passiamo attraverso una serie di esercizi di mobilità che mi fanno sentire come se stessi riscoprendo articolazioni di cui ignoravo l’esistenza.
Poi arriva il momento del WOD vero e proprio. Mi posiziono davanti a quello che dovrebbe essere un wall ball target, ma che in realtà sembra più un bersaglio per freccette malamente dipinto sul muro. Prendo una med ball e qui devo fare un inciso: questa med ball ha visto cose che voi umani… Ha una consistenza che oscilla tra il cuoio invecchiato e la pelle di un rinoceronte centenario. Sono abbastanza sicuro che se la tagliassi a metà, potrei contare gli anelli come per determinare l’età di un albero.
Il timer parte ed io mi tuffo nel WOD con la determinazione di chi vuole dimostrare che sì, anche in questo antro di fitness post-atomico si può fare un buon allenamento. I wall ball non sono male, anche se ogni volta che la palla colpisce il “target” ho paura che l’intero muro possa crollare.
Poi passando ai pull-up, mi rendo conto che la barra è… beh, diciamo “vissuta”. Ha più strati di nastro adesivo di una mummia egizia, e sono abbastanza sicuro che alcuni di quegli strati siano lì da prima che io nascessi. Ma stringo i denti e le mani, molto forte e vado avanti.
I power clean sono un’avventura a sé. Il bilanciere ha un equilibrio tutto suo, come se avesse sviluppato una personalità dopo anni di abusi. Ogni rep è una negoziazione: io cerco di sollevarlo, lui cerca di convincermi che forse sarebbe meglio se entrambi ci prendessimo una pausa.
Nonostante tutto, mi ritrovo a sudare, ansimare e… divertirmi? Sì, contro ogni previsione, sto effettivamente godendomi questo WOD in questo improbabile scenario. C’è qualcosa di grezzo, di autentico in questo posto che il mio box asettico e perfetto non ha.
Venti minuti passano in quello che sembra essere contemporaneamente un istante e un’eternità. Quando il timer suona, mi ritrovo disteso sul pavimento, cercando di non pensare troppo a quanto tempo sia passato dall’ultima volta che è stato pulito, accanto al settantenne, che sembra aver appena fatto una passeggiata nel parco.
“Non male, eh?”, mi dice lui, con un sorriso che potrebbe illuminare l’intero box meglio delle luci al neon tremolanti sul soffitto.
“Devo ammettere”, rispondo tra un respiro affannoso e l’altro, “che è stato… interessante.”
Bob/Nigel/Rupert si avvicina, con un’espressione di genuina soddisfazione sul volto. “Allora, che ne pensi del nostro piccolo box?”
E qui sta il dilemma. Cosa gli dico? Che il suo box sembra il set di un film post-apocalittico? Che ho seriamente temuto per la mia incolumità fisica almeno tre volte durante il WOD? Che sono piuttosto certodi aver visto un topo fare muscle-up su una trave del soffitto?
Ma poi guardo intorno. Vedo il ragazzo giovane che sta cercando di migliorare la sua tecnica del power clean, chiedendo consigli al settantenne. Vedo Bob/Nigel/Rupert che, nonostante l’aspetto trasandato, ha gli occhi che brillano di passione quando parla di CrossFit. Vedo una comunità, piccola ma unita, che si è formata in questo improbabile angolo di Londra.
Mi sorprendo a pencare, “c’è qualcosa di speciale qui.”
E lo penso davvero. Sì, il mio box di provenienza è più pulito, più organizzato, più… tutto. Ma qui c’è un’anima che non si può replicare con attrezzature nuove di zecca o pavimenti in gomma immacolati.
Mentre mi cambio negli “spogliatoi”, rifletto su questa esperienza. Il CrossFit, mi rendo conto, non riguarda solo l’avere l’ultimo modello di rower o il pavimento in gomma più costoso. Riguarda la comunità, la passione, il superare i propri limiti, anche quando quei limiti includono la paura di contrarre il tetano da un bilanciere.
Uscendo, do un’ultima occhiata al box. Bob/Nigel/Rupert sta già preparandosi un’altra tazza di tè. Il settantenne sta facendo stretching come se avesse appena deciso di iniziare la giornata, e il ragazzo giovane sta pulendo meticolosamente il suo spazio di allenamento.
E in quel momento, tra l’odore di sudore stantio e disinfettante industriale, capisco una cosa: il CrossFit, quello vero, non ha bisogno di lustrini. Vive nel sudore, nella magnesite, nelle mani callose e nei muscoli doloranti. Vive nella comunità che si forma attorno a una passione comune, che sia in un box all’avanguardia o in un seminterrato che sembra uscito da un romanzo di Dickens.
Mentre cammino verso la metropolitana, con i muscoli che protestano per l’allenamento appena concluso, mi ritrovo a sorridere. Sì, domani tornerò nel mio box svizzero, con i suoi spogliatoi immacolati e le sue attrezzature scintillanti. Ma una parte di me rimarrà in quel vecchio box londinese, dove il CrossFit è grezzo, autentico e sorprendentemente vivo.
E chissà, forse un giorno tornerò. Magari la prossima volta porterò un po’ di disinfettante da casa. Giusto per sicurezza.