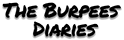C’è qualcosa di profondamente sadico nel modo in cui il CrossFit ti mette davanti ai tuoi limiti. Non parlo dei limiti fisici, quelli sono ovvi e in un certo senso, quasi rassicuranti nella loro oggettività. No, parlo di quei limiti mentali, quelle barriere che ti costruisci da solo e che, come un criceto in gabbia, ti ostini a non voler superare.
I double unders sono uno di quei movimenti che sembrano fatti apposta per umiliarti. Li guardi fare dagli altri e pensi: “Ma quanto può essere difficile far passare una corda due volte sotto i piedi mentre salti?”. Poi ci provi e realizzi che la coordinazione necessaria è paragonabile a quella richiesta per suonare il violino mentre cavalchi un unicorno su un monociclo. In equilibrio su una fune. Durante un terremoto.
Era febbraio 2014 quando il destino, sotto forma di Dave Castro e del suo perverso senso dell’umorismo, decise che il WOD 14.1 degli Open doveva includere i double unders. Gli Open, per chi non lo sapesse, sono quella fase dell’anno in cui ogni CrossFitter che si rispetti decide di mettersi alla prova contro il resto del mondo, anche se il resto del mondo non ha la minima idea della sua esistenza. È un po’ come quando da bambino giocavi a fare il supereroe nel cortile di casa, solo che qui hai un pubblico che ti guarda mentre fallisci miseramente.
“Non puoi non partecipare”, disse Niccolà, il coach del Box, con quel tono che usano i genitori quando ti dicono che devi mangiare le verdure. “Sei uno dei veterani, devi dare l’esempio.”
Veterano. La parola mi fece quasi ridere. Ero quello che alcuni chiamerebbero un “atleta maturo”; un eufemismo per dire “vecchio” nel mondo del fitness, con poco più di un anno di CrossFit alle spalle e una collezione di movimenti non ancora padroneggiati che farebbe impallidire un principiante. E ora dovevo “dare l’esempio”.
“Ma io non so fare i double unders”, protestai debolmente, sapendo già che era una battaglia persa.
“Beh, hai due settimane per impararli”, fu la sua risposta, accompagnata da quel sorriso che solo chi sta per infliggerti una tortura può avere.
Due settimane. Quattordici giorni per imparare qualcosa che alcuni ci mettono mesi a padroneggiare. Fantastico. Come se non bastasse, il WOD prevedeva anche dei power snatch, che nel mio caso erano più “power smash”, nel senso che più delle volte finivo per spaccare qualcosa, principalmente il mio ego.
Così iniziò la mia ossessione. Mi procurai una corda da salto, una di quelle speed rope che sembrano fatte apposta per trasformare le tue gambe in un’opera d’arte contemporanea fatta di lividi e segni rossi. La portavo ovunque. In ufficio, a casa, persino in macchina. Era come avere una relazione tossica con un serpente metallico.
Le prime sessioni furono… interessanti. Mi piazzavo in un angolo del Box, lontano dagli sguardi pietosi degli altri atleti, e iniziavo quello che sembrava un rituale di auto-flagellazione. Saltavo, la corda si impigliava, mi frustavo le caviglie, imprecavo, ripetevo. Era come una danza, solo che invece di essere elegante e fluida, assomigliava più a un attacco epilettico coreografato male.
Le persone che passavano mi guardavano con una miscela di pietà e perplessità. “Ma non era quello che faceva consulenza per le multinazionali?”, sentivo sussurrare. “Guardalo ora, sembra un bambino di prima elementare che ha bevuto troppi energy drink.”
La cosa peggiore? I consigli. Oh, i consigli. Tutti, ma proprio tutti, avevano la loro teoria su come fare i double unders. “Devi saltare più in alto”, “No, devi saltare più piano”, “Prova a ruotare i polsi più velocemente”, “Concentrati sul ritmo”. Era come essere in mezzo a un congresso di esperti di fisica quantistica, solo che invece di discutere della teoria delle stringhe, dibattevano su come far girare una corda attorno al proprio corpo.
Una sera, dopo l’ennesima sessione di frustate auto-inflitte, mi fermai a guardare un video tutorial su YouTube. L’istruttore, uno di quei tizi perpetuamente sorridenti che sembrano usciti da uno spot di dentifricio, spiegava come fare i double unders come se stesse insegnando a respirare. “È tutto nel ritmo”, diceva. “Jump-swing-swing, jump-swing-swing.” Già, come no. Nel mio caso era più “jump-tangle-swear-untangle-repeat”.
Ma sono testardo. O masochista. Probabilmente entrambe le cose. Ogni giorno, ogni singolo dannato giorno, tiravo fuori quella corda e provavo. Nel parcheggio prima di andare al lavoro. Durante la pausa pranzo. La sera prima di andare a letto. I miei vicini probabilmente pensavano che stessi praticando qualche strano rituale esorcistico, con tutti quei salti e quelle imprecazioni.
Il primo double under riuscito fu come vedere un unicorno. Ero talmente sorpreso che funzionasse che inciampai subito dopo, cadendo in modo spettacolare e poco dignitoso. Ma non importava. L’avevo fatto. Una volta. Ora dovevo solo… replicarlo. Centinaia di volte. In un WOD. Sotto pressione. Con il fiato corto. E il timer che correva. Niente di che.
Il problema dei double unders è che sono come le patatine: non puoi fermarti a uno. Nel WOD ne servivano molti di più, e consecutivi. E qui viene il bello: quando finalmente riesci a farne uno, il tuo cervello decide che è il momento perfetto per pensare “Ehi, guarda che ci stai riuscendo!” e in quel preciso istante, perdi il ritmo e ti ritrovi con la corda attorcigliata intorno alle caviglie come un serpente particolarmente vendicativo.
Fu durante uno di questi tentativi che mi procurai una lesione al tendine d’Achille. Niente di grave, ma abbastanza da farmi zoppicare per qualche giorno e da far preoccupare il fisioterapista che mi guardava come si guarda un bambino che ha appena mangiato un intero barattolo di Nutella: con un misto di disapprovazione e rassegnazione.
“Dovresti riposare”, mi disse.
“Non posso, ho gli Open tra una settimana”, risposi, come se stessi parlando delle Olimpiadi e non di una competizione in cui il mio massimo obiettivo era non finire ultimo.
Mi guardò come si guarda un caso clinico particolarmente interessante. “Sai che questa è tecnicamente una forma di auto-lesionismo, vero?”
“Si chiama dedizione”, corressi io. “O stupidità. Dipende da chi lo chiedi.”
La settimana prima degli Open fu un crescendo di intensità. Avevo sviluppato una tecnica tutta mia: saltare come se il pavimento fosse fatto di lava, roteare la corda come un elicottero impazzito e pregare tutti gli dei del fitness che qualcosa funzionasse. Sorprendentemente, ogni tanto funzionava davvero.
Il giorno del WOD 14.1 arrivò troppo presto e troppo tardi allo stesso tempo. Il Box era pieno di atleti, tutti con quella strana miscela di eccitazione e terrore negli occhi che caratterizza gli Open. C’era chi si scaldava metodicamente, chi ripassava la strategia, chi pregava in un angolo. Io ero lì, con la mia corda, a fare quello che avevo fatto per le ultime due settimane: saltare e sperare per il meglio.
“Tre, due, uno… GO!”
I primi minuti furono un blur di snatch e imprecazioni sussurrate. Poi arrivarono loro: i double unders. Il momento della verità. Presi la corda, feci un respiro profondo e iniziai a saltare.
E funzionò. Non so come, non so perché, ma funzionò. Non erano belli, non erano eleganti, probabilmente sembrava che stessi cercando di scacciare uno sciame di api invisibili, ma funzionavano. Li stavo facendo. Uno dopo l’altro, come una macchina ben oliata. OPk, forse più come un trattore arrugginito, ma comunque funzionante.
Quando finì il WOD, ero stremato, sudato e probabilmente in uno stato mentale alterato, ma ce l’avevo fatta. Avevo completato il mio primo workout degli Open, double unders inclusi.
Niccolà si avvicinò con quel suo solito sorriso. “Visto? Non era poi così difficile.”
Lo guardai come si guarda qualcuno che ti dice che la maratona “non è poi così lunga” mentre sei al chilometro 41. “La prossima volta che dici una cosa del genere, ti faccio mangiare la corda da salto.”
Rise. “Dai, ammettilo: ora ti senti invincibile.”
E aveva ragione, maledetto. Mi sentivo invincibile. Stupido, dolorante e probabilmente bisognoso di una TAC cerebrale, ma invincibile.
I double unders sono diventati una specie di metafora della mia esperienza nel CrossFit: qualcosa che sembra impossibile, che ti fa sentire un idiota mentre ci provi, che ti fa male in posti che non sapevi nemmeno di avere, ma che alla fine, con abbastanza ostinazione (e una buona dose di masochismo), riesci a padroneggiare.
Oggi, quando vedo qualcuno alle prese con i suoi primi double unders, con quella stessa espressione frustrata che avevo io, non posso fare a meno di sorridere. Non per deridere, ma perché so esattamente cosa sta passando. È quel momento magico in cui realizzi che il CrossFit non è solo about fitness, ma è soprattutto about non arrendersi mai, anche quando sembri un idiota che salta con una corda.
E sì, ogni tanto mi faccio ancora qualche frustata. Ma ora posso dire che è intenzionale. Più o meno.